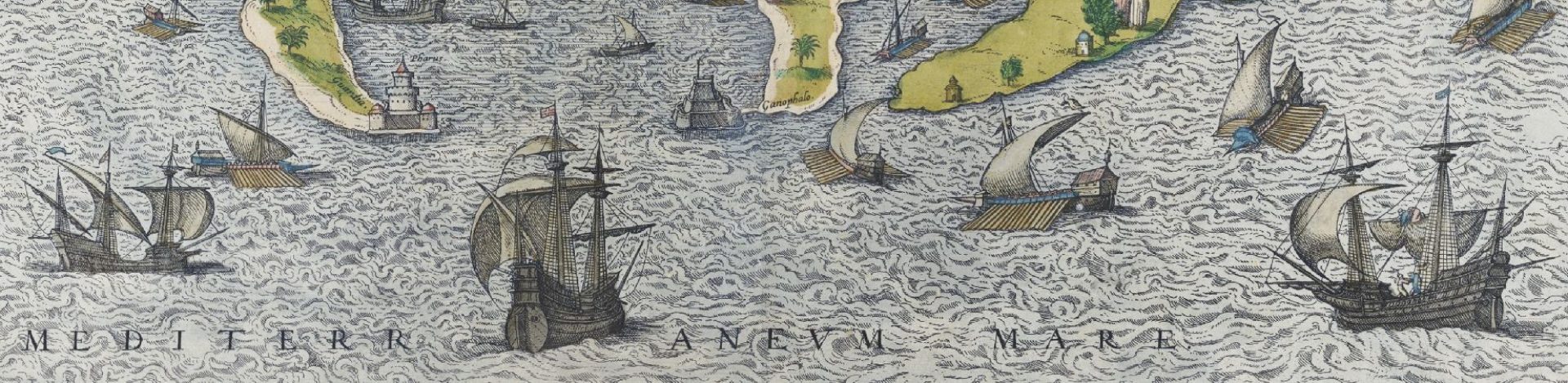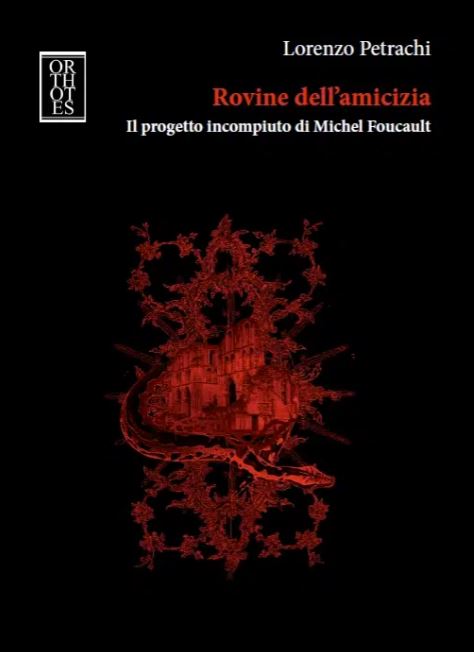 Lorenzo Petrachi, Rovine dell’amicizia. Il progetto incompiuto di Michel Foucault Orthotes Editrice, 2022.
Lorenzo Petrachi, Rovine dell’amicizia. Il progetto incompiuto di Michel Foucault Orthotes Editrice, 2022.
Ciunque ritiene di sapere cos’è un’amicizia, da cosa riconoscerla e come nominare i suoi gesti, quali rapporti debba intrattenere con l’amore, la famiglia o le asimmetrie; oltre quali soglie non può spingersi, pretendere e ambire – quantomeno non in maniera ragionevole. Ma ci si potrebbe chiedere: attraverso quali avvenimenti imprevisti, per quali giochi del vero e del falso, a opera di quali torsioni del pensiero e del sentimento, soprattutto contro chi abbiamo potuto acquisire quest’evidenza? Com’è accaduto che all’amicizia spettasse una forma specifica d’esperienza con le sue norme e i suoi vissuti?
Rispondere a questi interrogativi vuol dire confrontarsi con il compito di una storia del presente, pratica i cui contorni sono stati delineati da Michel Foucault, che nel 1982 dichiarava: «se c’è una cosa che mi interessa, oggi, è il problema dell’amicizia. Dopo aver studiato la storia della sessualità, bisogna comprendere la storia dell’amicizia». Si tratta, in questo lavoro, di saggiare la possibilità e il valore di questa storia.
L’amicizia appare nell’immediato come qualcosa di privato e indipendente dalle relazioni di potere, si definisce anzi tramite una sospensione di tutta una serie di relazioni (gerarchiche, sessuali, di dipendenza) che non possono incrociarla, pena il suo snaturamento. Ma che l’amicizia esista, che abbia una natura – e che possa dunque venire snaturata – è qualcosa di cui bisogna rendere conto.
“Durante i suoi ultimi anni di vita, Foucault utilizza in più occasioni il termine “problematizzazione” per riferirsi tanto all’oggetto delle sue ricerche quanto allo stile di pensiero che le informa e le sostiene. Con questa parola egli indica «l’insieme di pratiche discorsive e non discorsive che fanno entrare qualcosa nel gioco del vero e del falso e lo costituiscono come oggetto per il pensiero», vale a dire ciò attraverso cui «l’essere si dà come essere che può e deve essere pensato». L’intero percorso cominciato negli anni Sessanta con la Storia della follia viene adesso presentato dall’autore nelle vesti di un’indagine storica – polimorfa e internamente differenziata – relativa alle diverse modalità di problematizzazione: «la dimensione archeologica dell’analisi permette di analizzare le forme stesse della problematizzazione; la sua dimensione genealogica, la loro formazione a partire dalle pratiche e dalle loro modificazioni».
La recezione di questa categoria è stata segnata – se non compromessa – dalla diffusione e dal consolidamento della griglia interpretativa secondo cui nell’opera foucaultiana vi sarebbero tre fasi successive e facilmente distinguibili. In questa prospettiva – almeno in parte promossa dallo stesso Foucault e, a parere di chi scrive, patentemente inconsistente – a un primo momento di analisi del discorso, seguirebbe prima lo studio microfisico del potere e infine un ritorno (pentito) al soggetto e alla sua etica. Ora, parallelamente a questa tripartizione, si dispiegherebbe l’avvicendarsi di altrettante fasi metodologiche: l’archeologia, la genealogia e, in ultimo, il metodo delle problematizzazioni. Quest’interpretazione sottostima enormemente il ruolo strutturale della nozione di problema nel contesto della filosofia foucaultiana: a ben vedere, tanto il progetto archeologico quanto il metodo genealogico affondano le loro radici in uno «stile di pensiero che procede come indagine sui problemi che motivano e facilitano, in risposta, lo sviluppo di nuove pratiche, tecniche e stili».